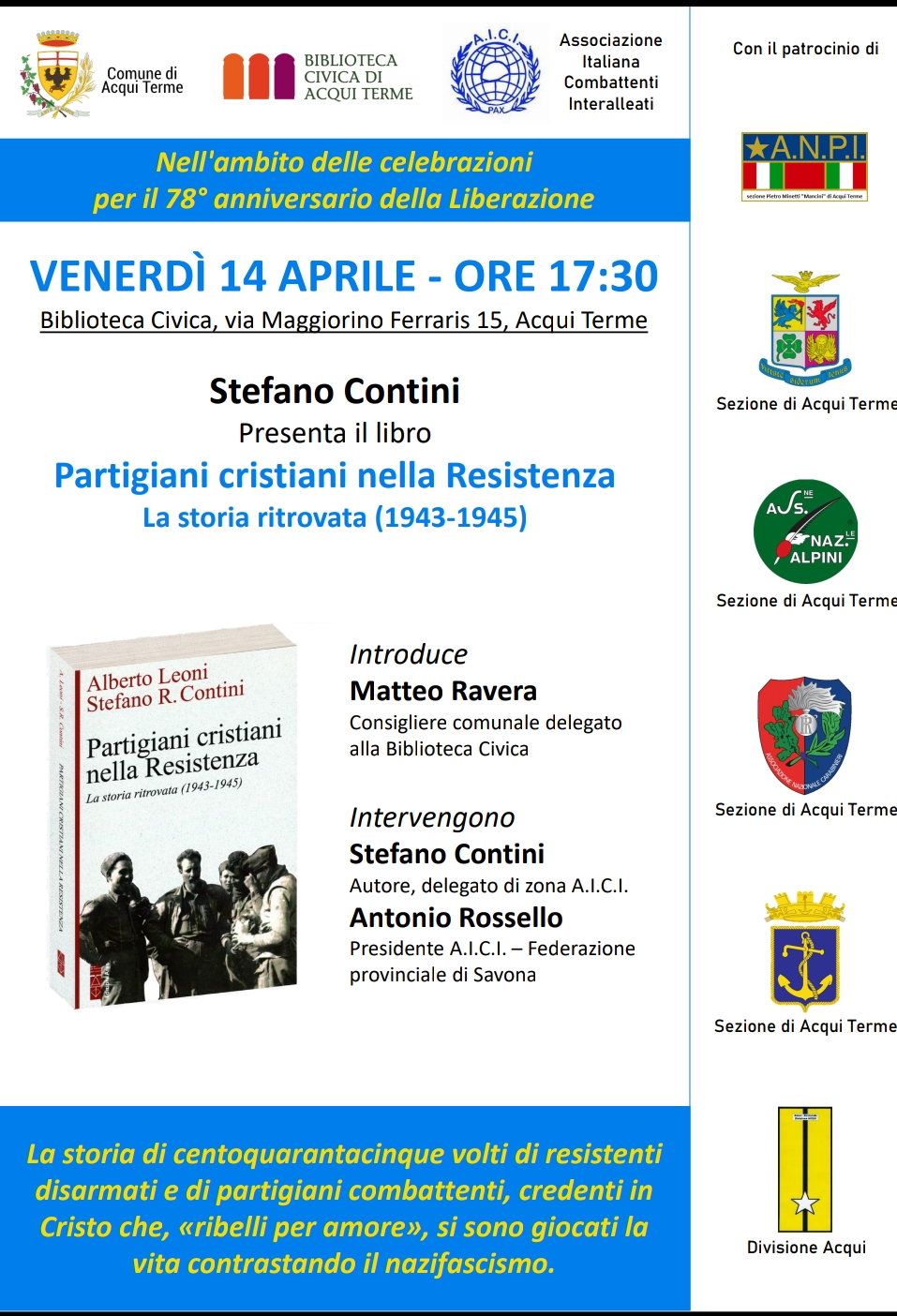Pubblichiamo un contributo della scrittrice e blogger Renata Rusca Zargar.

Oggi, in occasione della Giorno del Ricordo, pubblico qui un mio racconto.
ULISSE
di Renata Rusca Zargar
Il treno incede sui binari mentre il paesaggio verde avanza al di là del finestrino. Dicono che ci sia un guasto sulla linea e per questo si proceda lentamente.
Elisa osserva quei luoghi tanto spesso descritti dalla nonna, quel rigoglio di alberi e di foglie che fa immaginare un ribollire sotterraneo di acque, di grotte, di anfratti…
Forse, durante la notte, si alzano dalle fosse nascoste le anime irrequiete di chi non ha trovato degna sepoltura e ancora grida nel soffio del vento: “Non dimenticare… Non dimenticare…”. Nel buio galleggiano allora gusci spettrali in una densa nebbia che racchiude la storia: poveri Italiani dai sogni spezzati, torturati, gettati ancora vivi nelle foibe…
Quante volte la nonna le ha raccontato le sue vicende!
“La polizia politica partigiana, l’Ozna, stendeva le liste di chi era ‘nemico del popolo’. Di notte, avevamo il terrore di sentire quei passi sulle scale, si sapeva che i prelevati venivano puniti senza indagini o processo: chi non periva nella tortura finiva nelle foibe. Là davanti, venivano legati loro i polsi e i piedi con il fil di ferro e poi uniti agli altri sempre con il fil di ferro. I massacratori sparavano al primo del gruppo che cadeva nella foiba, trascinando i compagni. Chi era deportato, invece, era destinato a morire di stenti, di percosse o giustiziato lungo la strada verso la detenzione. Il nonno, che era medico, era stato arrestato. Di lui non si sapeva più niente, ogni giorno andavo a chiedere notizie, alla fine qualcuno mi aveva risposto brutalmente di andarmene, se non volevo fare la stessa fine insieme ai miei tre figli!”
Ora Elisa è lì, finalmente, a visitare quei paesi, alla ricerca del nonno disperso e di qualche testimonianza o notizia, chissà… Su quel soggetto farà la sua tesi di laurea, lo deve alla sua famiglia travagliata, ai parenti perduti, alla nonna che non c’è più…
Dopo qualche giorno trascorso a Trieste per visitare la Risiera di San Sabba, Elisa si era trasferita a Pisino. Là, aveva iniziato a studiare dei documenti conservati nel Museo Civico del castello di Montecuccoli.
Ogni notte, dopo una giornata di ricerche, le sembrava di vederli, quei gusci di anime fluttuanti nella nebbia, a chiedere giustizia, a salire su dall’orrido della foiba, a pregarla di fare una tesi accurata perché nulla venisse dimenticato!
In uno dei tanti documenti custoditi nel Museo aveva letto un’ordinanza: “P.N.F. Comando Squadristi-Dignano- Attenzione! Si proibisce nel modo più assoluto che nei ritrovi pubblici e per le strade di Dignano si canti o si parli in lingua slava. Anche nei negozi di qualsiasi genere deve essere una buona volta adoperata SOLO LA LINGUA ITALIANA. Noi Squadristi, con metodi persuasivi, faremo rispettare il presente ordine. GLI SQUADRISTI.”
Ecco, poi, i risultati di un trattamento tanto disumano nei confronti di chi non era Italiano e che non riguardava certo solo Dignano ma tutti gli altri territori: gli Italiani, dopo la fine della guerra, erano stati considerati squadristi fascisti e avevano subito la brutale vendetta.
A loro volta, gli Italiani avevano dovuto scegliere: optare per la cittadinanza italiana o jugoslava. A seconda della scelta, si rimaneva o si emigrava. Molti scappavano spaventati dalle minacce, dall’arresto o dalla sparizione di parenti e amici… E dove andavano? L’Argentina- si leggeva, sempre nei documenti- aveva interesse a popolare l’immenso territorio e quindi accoglieva gli immigrati con uffici collocamento, ambulatori medici, interpreti, corsi di formazione al lavoro: così, essi si impiegavano nelle tenute agricole e nell’industria della carne. Là erano emigrati gli zii di sua madre. Anche New York, fin dall’inizio del secolo, offriva lavoro sulle navi da carico e sui rimorchiatori, oppure gli esuli andavano in California dove, terminata la febbre dell’oro, tagliavano il legno nei boschi di sequoie…
La sorella della nonna era, invece, emigrata, con il marito, in Australia, dopo aver subito torture e violenze. Si era portata un lenzuolo di lino tessuto a mano e, tagliandolo in quadrati, aveva creato poi dei centrini decorati a mano. Quei lavori erano piaciuti e lei si era guadagnata da vivere fintanto che non era morta, ancora giovane, probabilmente per le sofferenze subite nel suo paese. Con la nonna non si erano più riviste.
Quante vite lacerate, famiglie distrutte, divise, sparse per il mondo!
Il Museo non era molto frequentato: qualche volta, arrivava qualche classe di studenti e un insegnante spiegava loro ciò che era successo. I ragazzi apparivano compresi di tanta tragedia; qualche adulto, forse parente di esuli o di infoibati, piangeva.
C’era, però, un giovane biondo dagli occhi verdi che studiava i documenti, come lei. Ogni tanto le lanciava un’occhiata, ma non le aveva mai rivolto la parola. E d’altra parte chissà se si sarebbero capiti: egli parlava con l’usciere in croato.
Dopo qualche settimana, Elisa si era spostata a Rovigno. Là aveva visitato il Liceo italiano: scuola in lingua italiana, appunto, che si rivolgeva alla minoranza, circa l’11% della popolazione.
Poi, si era recata nel Centro Ricerche Storiche.
Il giorno dopo, però, era giunto il giovane che aveva già intravisto a Pisino. Anche lui faceva la stessa indagine ed era stato inevitabile, a quel punto, parlarsi, nonostante egli non conoscesse l’italiano.
Si chiamava Franco Franjo, era croato, abitava con la famiglia proprio a Pisino.
Come Elisa, aveva scelto quell’argomento per la sua tesi di laurea.
–Nel mio paese, –le aveva detto in inglese- non è un argomento molto approfondito, anzi, fino a poco tempo fa, non se ne parlava per niente. Si dice, comunque, che gli Italiani fascisti che avevano tiranneggiato la popolazione slava siano stati puniti, seppure, forse, troppo ferocemente.-
-No, non è così!- aveva ribattuto Elisa- Gli Italiani non erano tutti fascisti, anzi, molti erano oppositori della dittatura, eppure sono stati trattati nello stesso modo, sono stati perseguiti semplicemente perché erano Italiani! Anche in Italia, non si volevano accogliere gli esuli per lo stesso motivo. Ma sbagliavano.- Franco la guardava in silenzio.
-Nella mia famiglia, ad esempio, – aveva continuato Elisa -non c’erano fascisti! Il fratello di mio nonno è stato imprigionato dai tedeschi nella Risiera di San Sabba perché era partigiano e da lì è stato internato a Buchenwald, dove è morto. I parenti di mia madre, che avevano scelto di combattere con l’Italia durante la prima guerra mondiale, poi sono stati perseguitati dal regime di Mussolini e sono stati mandati al confino! Essere Italiani non significava certo essere fascisti!-
Elisa si accalorava a quegli argomenti perché sentiva su di sé il dolore di tante persone torturate, uccise, costrette dal terrore a lasciare per sempre luoghi tanto amati e per i quali avevano lottato, credendo che dovessero essere italiani, così come loro si sentivano dentro.
– È stata un’autentica pulizia etnica, e lo si vede dalle cifre: le zone contese contavano circa un milione di abitanti italiani nel 1940; sono rimasti solo circa 60/70.000 dopo che i territori sono divenuti jugoslavi.-
Nei giorni seguenti, i due giovani avevano deciso di lavorare insieme alla ricerca e di condividere le informazioni che via via venivano alla luce dalla lettura dei numerosi documenti.
Elisa alloggiava in una pensioncina di Rovigno. Franco, invece, ogni sera tornava a casa a Pisino.
Una volta, però, Franco si era fermato con lei a cena. Avevano scelto la Pizzeria “Da Sergio” perché faceva un’ottima pizza italiana, anche se era gestita da una famiglia rovignese. Si erano seduti a un tavolo fuori, proprio in uno di quei vicoli caratteristici del centro storico, e avevano chiacchierato fino a tardi. Poi, avevano fatto una passeggiata: Rovinj, come la chiamava Franco, era una cittadina magicamente bella. La sua costa frastagliata, fronteggiata da scogli e isolotti le ricordava quella poesia di Saba, Ulisse, alla quale si sentiva molto vicina:
Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d’onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d’alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l’alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.
Anch’ella era ancora alla ricerca della verità, della conoscenza, ben lontana da un porto sicuro ove ancorare la sua vita. La storia di Rovigno, poi, era simbolo di tutto ciò che sempre le era stato raccontato: città romana, un tempo, poi appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia, quindi all’Impero Austro-Ungarico fino al termine della prima guerra mondiale. Italiana fino al Trattato di Parigi del 1947, ceduta dunque alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, fatto che aveva causato l’esodo della maggioranza della popolazione italiana autoctona, che costituiva la quasi totalità (circa 10000 persone, il 97% degli abitanti secondo un censimento austriaco del 1911) dei residenti. Quasi l’85% se ne era andato, rimpiazzato in gran parte da cittadini croati e rimaneva solo una piccola comunità, forse 1650 persone, di cui molti ancora nascondevano la propria identità per paura.
Ma non era quello che pensava in quei momenti mentre, mano nella mano, con il suo compagno, percorreva le stradine della stupefacente penisola del centro cittadino sotto la Torre dell’Orologio e discorreva dei loro progetti futuri. Dopo la laurea, egli avrebbe voluto continuare come ricercatore all’Università. Lei avrebbe desiderato, invece, diventare insegnante di storia in una scuola superiore per riempire quel vuoto di conoscenze che non era ancora stato colmato. La passione per lo studio e l’approfondimento delle consapevolezze era, comunque, comune.
Davanti al mare della notte, con le luci dell’abitato all’intorno e un paradiso di stelle, lui l’aveva stretta e baciata. Da giorni, ambedue aspettavano quel momento, da giorni si osservavano, parlavano, si sentivano in perfetta sintonia… Quindi, i sogni si erano uniti ai sogni, quando tutto tace ed è solo il cuore a bisbigliare piano. Ma anche la ragione aveva il suo spazio: essi avrebbero potuto condividere non solo la passione l’uno per l’altra ma anche lo studio, l’analisi, il lavoro… Avrebbero potuto credere in un progetto di vita comune, in un futuro insieme.
Proprio di ciò avevano discusso nei giorni seguenti, mentre la stesura della tesi procedeva a pieno ritmo.
C’era solo un fatto strano che turbava Elisa: di notte le appariva in sogno il nonno che non aveva mai conosciuto se non in fotografia. Egli la osservava senza dire nulla, ma sembrava tanto triste. Perché triste, nonno? Sto cercando per te la verità, poi la porterò in Italia e molti, finalmente, sapranno. Se un giorno sarò insegnante, continuerò a divulgare la realtà che ormai si sta imponendo, per tanti anni nascosta e dimenticata. Lo so, il tuo cadavere rimarrà insepolto per sempre, nessuno lo troverà mai tra tante migliaia, ma la tua memoria sarà rispettata, l’amore degli Italiani di questi luoghi per l’Italia risplenderà puro e limpido come le stelle del cielo.
L’alba fugava quelle sensazioni di disagio perché poco dopo rivedeva lui, il suo Franco: con lui trascorreva tutta la giornata, mai stanca di guardarlo, di assorbire le sue movenze, i suoi gesti, le sue parole. Solo, qualche volta, anche a lui passava un’ombra negli occhi che subito dissipava stringendole le mani o abbracciandola.
-Quando avremo finito qui,- prospettava Elisa- verrai con me in Italia, a Savona, ti farò conoscere la mia Liguria e la mia famiglia. Vedrai, ti piaceranno.-
Franco annuiva.
Eppure, avrebbe potuto anch’egli farle conoscere la sua famiglia che era a pochi chilometri da lì, ma non l’aveva mai proposto. Forse, non si sentiva sicuro dei suoi sentimenti? No, era impossibile, egli l’amava almeno tanto quanto lei, si capiva benissimo. Forse, non era ricco, abitava in una casa modesta, e si vergognava a mostrargliela… Ma a lei non importava nulla, contava solo quello che avrebbero fatto loro, non certo ciò che era stato prima!
Ormai, erano passati alcuni mesi, la tesi era alla conclusione, Elisa sarebbe presto partita per l’Italia.
Così, sempre davanti a quel mare che nascondeva scogli pronti a far perdere e distruggere un navigante inesperto, Franco le aveva detto che doveva parlarle di cose gravi.
Elisa aveva ascoltato in silenzio: il nonno di Franco era un comandante partigiano di Tito, una di quelle persone che avevano la responsabilità di tante condanne senza processo, di tanti internamenti e marce forzate in campi di concentramento in Jugoslavia, di tante uccisioni, di tanti annegamenti in mare con una pietra al collo e infoibamenti. Chissà, nessuno poteva saperlo, ma avrebbe potuto persino essere il diretto responsabile dell’uccisione di suo nonno.
Franco aveva voluto studiare quell’argomento per capire quel poco che aveva saputo in famiglia e ora si sentiva prigioniero di tanto orrore. Ora comprendeva quello che era stato fatto contro persone nella maggior parte incolpevoli, inermi, che solo amavano quella che avevano sempre creduto la propria patria. Non aveva avuto il coraggio di dirle tutto prima perché l’aveva amata fin dal primo incontro, nel Castello di Montecuccoli, e non voleva perderla…
Dopo la confessione, egli l’aveva guardata come in attesa di un verdetto: ora era suo il processo, forse il castigo, nonostante anch’egli non avesse fatto nulla di male. Avrebbe pagato per le colpe dei padri?
Elisa si era avviata, senza parlare, al suo albergo. Lui non l’aveva seguita. Il mattino dopo, prestissimo, era partita.
Ecco perché suo nonno, in sogno, era tanto triste! Sapeva che lei amava il suo carnefice! Come avrebbe potuto sposare un uomo che aveva un passato tanto terribile? Come avrebbe potuto incontrare la sua famiglia? Come i loro figli avrebbero potuto chiamare bisnonni quelli che avevano fatto annientare gli altri bisnonni?
Non si poteva condividere la vita con chi era tanto diverso!
Il treno scivolava lento sulle rotaie: il paesaggio verde si allontanava inarrestabile…
Si era appisolata un attimo e le era sembrato di scorgere uno di quei gusci di anime, quello del nonno. Sorrideva e le indicava il ritorno indietro.
Forse, avrebbe potuto perdonare: superare il passato e iniziare un diverso cammino di pace. Forse, l’odio tra le famiglie, come i Montecchi e i Capuleti, si sarebbe stemperato nel nulla, un giorno. Forse, la loro unione avrebbe potuto essere, infine, la conclusione del dolore di un popolo. Forse lei, Ulisse, avrebbe trovato riparo e ristoro nel suo porto, tra le braccia di Franco.
Oppure, Il porto / accende ad altri i suoi lumi; me al largo / sospinge ancora il non domato spirito, / e della vita il doloroso amore.
Allora, ella avrebbe continuato, per tutta l’esistenza, a vagare al largo, tra le onde.
NOTIZIE STORICHE:
Le foibe sono inghiottitoi naturali tipici delle aree carsiche. Infatti, nella Venezia Giulia (ex province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume) le foibe vennero utilizzate, durante la Seconda guerra mondiale e nel dopoguerra, per liberarsi dei corpi di coloro che erano caduti a causa degli scontri tra nazifascisti e partigiani. Soprattutto, però, servirono a occultare le vittime della violenza di massa scatenata nell’autunno del 1943 e, poi, nella primavera del 1945, da parte del movimento di liberazione sloveno e croato e delle strutture del nuovo Stato iugoslavo creato da Tito. Furono principalmente i cadaveri di vittime delle fucilazioni a essere gettati nelle foibe e in altre cavità artificiali, quali, per fare un esempio, le cave di bauxite dell’Istria oppure il pozzo della miniera di Basovizza (divenuto poi monumento nazionale perché nel 1945 vi fu gettato un numero imprecisato e ingente di persone). Purtroppo, in alcuni casi, venivano precipitate anche persone ancora in vita. Le esplorazioni di tali cavità sono state ostacolate dall’ingente massa di materiali, compresi proiettili inesplosi, che vi furono gettati dagli iugoslavi allo scopo di celare la strage, e non hanno prodotto significativi risultati. Non tutte le vittime delle due ondate di violenza hanno però trovato la morte nelle foibe: anzi, buona parte degli scomparsi perì in altro modo, soprattutto nelle carceri e nei campi di concentramento iugoslavi. Tuttavia, il forte impatto emotivo derivante dalla scoperta dei primi ‘infoibamenti’ nell’ottobre del 1943, ha fatto sì che da quel momento il termine foibe fosse usato per definire nel loro complesso le stragi avvenute nella Venezia Giulia, mentre infoibati sono stati in genere considerati tutti coloro che vennero uccisi nel corso delle medesime stragi. Le ipotesi più attendibili riguardo tali omicidi parlano di circa 600-700 vittime per il 1943, quando a essere coinvolta fu soprattutto l’Istria, e di più di 10.000 arrestati – in massima parte, ma non esclusivamente, di nazionalità italiana -, alcune migliaia dei quali non fecero ritorno nel 1945, quando l’epicentro delle violenze fu costituito da Trieste, Gorizia e Fiume. Nel complesso, un ordine di grandezza tra le 4000 e le 5000 vittime sembra essere attendibile; cifre superiori si raggiungono soltanto conteggiando anche i caduti che si ebbero da parte italiana nella lotta antipartigiana. La prima ondata di violenze si ebbe dopo l’8 settembre. Crollate le strutture dello Stato italiano, i tedeschi occuparono in un primo momento soltanto i centri strategici di Trieste, Pola e Fiume, mentre nell’interno dell’Istria il potere venne assunto dal movimento di liberazione iugoslavo. In un quadro di generale confusione, insorsero i contadini croati, affluirono le formazioni partigiane operanti nell’entroterra croato e ovunque vennero instaurati i ‘poteri popolari’. Subito cominciarono gli arresti. Accanto a squadristi e gerarchi locali vennero prelevati podestà, segretari e messi comunali, carabinieri, guardie campestri, esattori delle tasse e ufficiali postali: un segno questo della diffusa volontà di spazzare via chiunque potesse far ricordare l’amministrazione italiana. Bersaglio delle retate divennero anche i possidenti italiani, molti dirigenti, impiegati, nonché capisquadra di imprese industriali, cantieristiche e minerarie. Il campo delle violenze si allargò fino a coinvolgere tutte le figure maggiormente rappresentative delle comunità italiane (dagli avvocati alle levatrici), vittime di una fiammata di furore nazionalista. Significativamente, negli stessi giorni, a Pisino, il Comitato popolare di liberazione proclamò l’annessione della regione alla Croazia e la cittadina divenne il centro della repressione: vi fu creato un tribunale rivoluzionario e nel castello fu concentrata la maggior parte degli arrestati provenienti da altre località dell’Istria. Di questi, numerosi furono uccisi nel corso delle successive settimane di settembre, molti altri vennero eliminati in massa ai primi di ottobre quando, di fronte a un’offensiva tedesca, le autorità popolari decisero di liberarsi di tutti i prigionieri, i quali potevano trasformarsi in pericolosi testimoni. Fonti croate del tempo confermano come uno dei compiti prioritari affidati ai poteri popolari in Istria fosse proprio quello di ‘ripulire’ il territorio dai ‘nemici del popolo’: una formula questa che, nella sua indeterminatezza, si prestava a comprendere tutti coloro che non collaboravano attivamente al movimento di liberazione. La seconda ondata di violenze di massa ebbe inizio nei primi giorni di maggio del 1945, quando le truppe iugoslave giunsero nella Venezia Giulia. Appena cessati i combattimenti, infatti, centinaia di militari della Repubblica sociale italiana caduti prigionieri furono passati per le armi (lo stesso accadde a quelli tedeschi) e migliaia di altri furono avviati verso i campi di prigionia – fra i quali particolarmente famigerato fu quello di Borovnica – dove fame, violenze e malattie mieterono un gran numero di vittime. Nella logica dell’eliminazione delle forze armate nemiche esistenti sul territorio rientra anche la deportazione delle unità della Guardia di Finanza, che non avevano mai partecipato ad azioni antipartigiane, e di molti membri della Guardia civica di Trieste. In entrambi i casi, si trattava di formazioni che, largamente infiltrate dal Comitato di liberazione nazionale (CLN), avevano partecipato sotto i suoi comandi alla battaglia finale contro i tedeschi, e tale circostanza permette di chiarire come l’obiettivo reale dell’azione repressiva condotta nei loro confronti consistesse nella liquidazione di qualsiasi forma di potere armato non inquadrato nell’armata iugoslava. Conseguentemente, a essere perseguitati furono anche i combattenti delle formazioni partigiane italiane, le quali, sotto la guida del CLN, avevano lanciato il 30 aprile a Trieste un’insurrezione contro i tedeschi, apertamente concorrenziale rispetto alla liberazione che arrivava sulla punta delle baionette iugoslave. Contemporaneamente, le autorità iugoslave diedero il via a un’ondata di arresti che diffuse il panico tra la popolazione italiana, soprattutto a Trieste e Gorizia. Parte degli arrestati venne subito eliminata, molti di più vennero deportati e perirono spesso in prigionia. Obiettivi delle retate, oltre ai membri dell’apparato repressivo nazifascista (fra i quali gli aguzzini dell’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, le cui atrocità erano state invano denunciate fin dal 1942 dal vescovo di Trieste), ai quadri del fascismo giuliano, e a elementi collaborazionisti, furono anche partigiani italiani i quali non accettavano l’egemonia iugoslava ed esponenti del CLN giuliano – dal quale i membri del Partito comunista italiano (PCI) erano usciti fin dall’autunno del 1944, per aderire alle tesi iugoslave – con sloveni anticomunisti e a molti cittadini privi di particolari ruoli politici, tuttavia di chiaro orientamento filoitaliano. Sloveni e croati contrari al nuovo regime non vennero trattati meglio degli italiani. Il tema delle foibe ha suscitato fino agli ultimi anni del 20° sec. limitato interesse nella storiografia italiana, e ciò per almeno due ragioni. In primo luogo, la generale disattenzione per le vicende del confine orientale, su cui pesavano gli echi di una stagione di conflittualità fra Italia e Iugoslavia che, a partire dagli anni Sessanta, appariva del tutto superata e che si preferiva quindi non ricordare. In secondo luogo, la rimozione compiuta da parte della storiografia di sinistra, che scontava sull’argomento le difficoltà derivanti dal sostegno offerto nel 1945 dai comunisti giuliani all’amministrazione iugoslava responsabile degli eccidi, dalla politica tutt’altro che lineare tenuta dal PCI sulla questione di Trieste, e dalla diffusa ammirazione per il ‘modello iugoslavo’. A ogni modo, nel corso di un sessantennio si sono succedute varie proposte interpretative. Del tutto prive di senso si sono così dimostrate le ipotesi negazioniste – già dominanti nella storiografia iugoslava – che avevano ripreso, trasformandolo in ‘verità di Stato’, il giudizio espresso fin dal 1945 dal governo di Tito, secondo il quale “da parte del governo jugoslavo non furono effettuati né confische di beni, né deportazioni, né arresti, salvo che […] di persone note come esponenti fascisti di primo piano o criminali di guerra” (nota iugoslava del 9 giugno 1945). Speculare alla precedente, è la tesi del ‘genocidio nazionale’ degli italiani. A parte il numero delle vittime – certo elevato, ma lontano da qualsiasi dimensione di genocidio – la repressione iugoslava del 1945 ebbe infatti sicuramente anche finalità intimidatorie nei confronti dell’intera comunità italiana: esse però sembrano da collegare non tanto a un progetto di espulsione, che prese corpo soltanto in anni successivi, quanto alla volontà di far comprendere nel modo più drastico agli italiani che sarebbero potuti sopravvivere nelle terre passate sotto il controllo iugoslavo solo se si fossero adattati senza riserve al nuovo regime, accettandone tutte le conseguenze di ordine politico, nazionale e sociale. Maggiore spessore hanno alcune valutazioni elaborate a partire dagli anni Settanta del 20° sec. (G. Fogar, G. Miccoli, T. Sala), che hanno consentito di inserire gli episodi del 1943 e del 1945 all’interno di una più lunga vicenda di oppressione e di violenze, iniziata con la politica snazionalizzatrice del fascismo nei confronti degli sloveni e dei croati, proseguita con l’aggressione italiana contro la Iugoslavia e culminata con la repressione nazifascista contro il movimento partigiano. In tale prospettiva, le stragi sono apparse un fenomeno di reazione largamente spontaneo, una sorta di brutale e spesso indiscriminata ‘resa dei conti’ da parte di popolazioni esasperate nei confronti dei loro persecutori. Si è così pervenuti a una prima storicizzazione del fenomeno, con l’individuazione delle responsabilità del fascismo nello scoppio della crisi che travolse l’italianità adriatica. Non si deve dimenticare, infine, il processo della presa del potere in Iugoslavia da parte di un movimento rivoluzionario a guida comunista, protagonista di una guerra di liberazione che era anche guerra civile diretta all’eliminazione fisica degli avversari, i cui echi si prolungarono, in termini di scontri armati e di uccisioni, fino al 1946. Un progetto che era al tempo stesso nazionale e ideologico, dal momento che consisteva nell’annessione della Venezia Giulia alla Iugoslavia comunista.
(da Enciclopedia Italiana Treccani)
La risiera di San Sabba è stato un campo di concentramento nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato come campo di detenzione di polizia (Polizeihaftlager), nonché per il transito o l’uccisione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici ed ebrei. Oltre ai prigionieri destinati a essere uccisi o deportati, vi furono imprigionati anche diversi civili catturati nei rastrellamenti o destinati al lavoro forzato. Le vittime (stimate fra le 3000 e le 5000, sulla scorta delle testimonianze raccolte) venivano fucilate, uccise con un colpo di mazza alla nuca, impiccate oppure avvelenate con i gas di scarico di furgoni appositamente attrezzati.